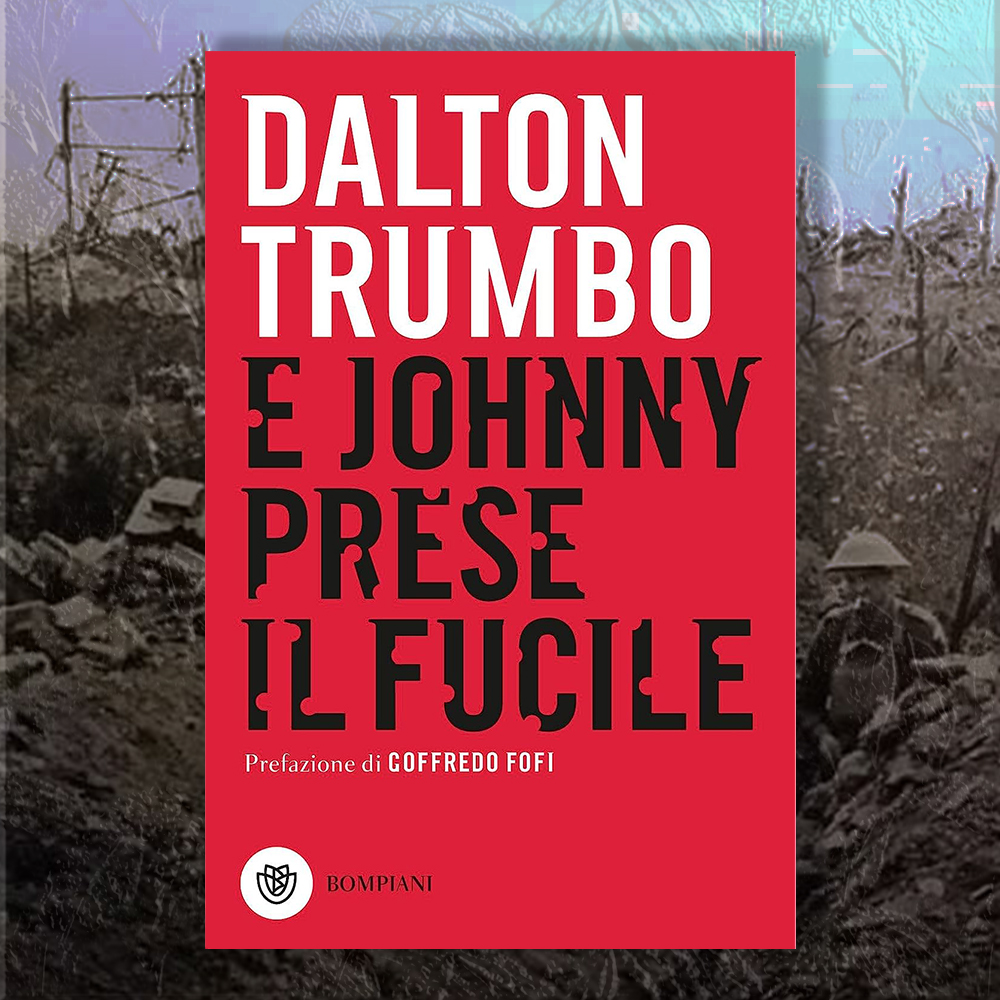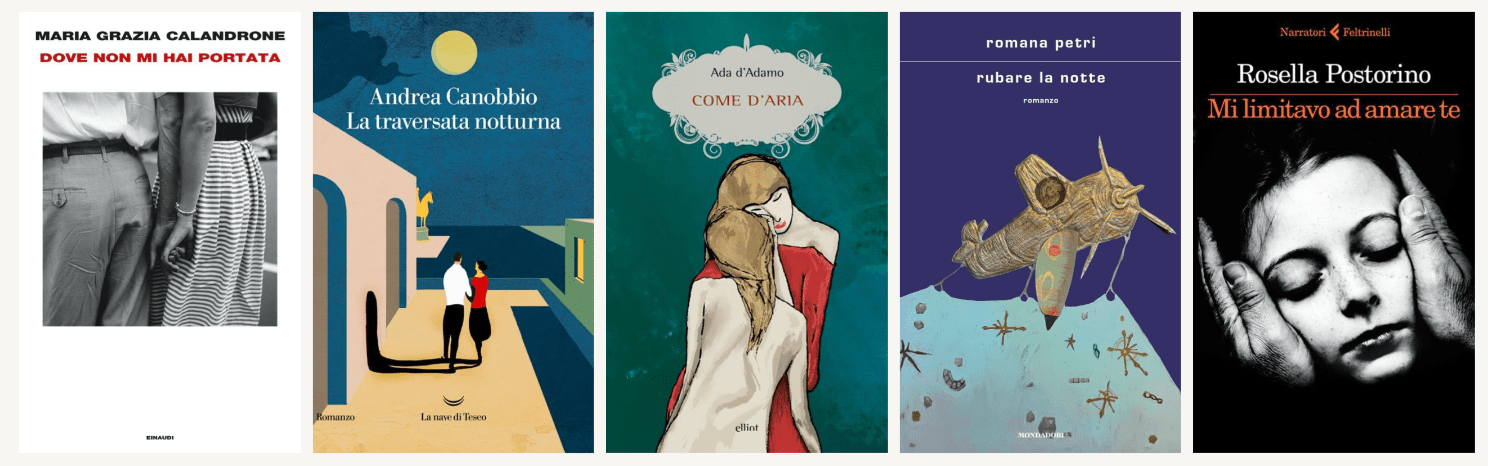“La bella estate” di Cesare Pavese è il romanzo di formazione da cui nel 2023 è stato tratto l’omonimo film.
Pubblicato per Einaudi nel 1949, La bella estate è il romanzo breve di formazione che dà il titolo a una silloge composta da tre racconti. Il titolo richiama il momento dell’anno in cui è più facile che sboccino amori e nuove esperienze, che si rinnovino promesse e illusioni.
Nell’estate del 1938, la giovane campagnola Ginia sogna una vita diversa, ravvivata dall’arte e da un respiro di libertà. Giunta a Torino per cercare lavoro, stringe amicizia con una ragazza più grande di lei, Amelia, che lavora come modella per alcuni pittori e che la introduce nell’ambiente artistico della città. Ambigue serate in compagnia e accese discussioni si intervallano a momenti di ozio e indolenza. È in questo scenario che conosce Guido, il giovane artista di cui si innamora, e grazie al quale conoscerà amore e disillusioni.
Diversamente delle opere pavesiane più note, anziché in collina o in realtà rurali, La bella estate si svolge in città, Torino. Se la collina e la campagna langarole di Pavese sono luoghi popolati da personaggi affondati nella semplicità contadina, genuini e reali, custodi dei valori sicurezza e serenità, in La bella estate la città assume i contorni contaminati e dissoluti di una realtà ai limiti. Indagata è quella giovane generazione bohemienne di artisti che popola atelier e conduce vite senza un reale spessore. Personaggi corrotti dai vizi, privi della capacità di costruzione e di presa di responsabilità, inafferrabili e inaffidabili.
Tra questi rappresentanti di un’umanità inquieta e incerta, si introduce la giovane campagnola Ginia, piena di ingenue illusioni e aspettative
La scrittura di Pavese, limpida e asciutta, coglie con grande sensibilità le sfumature psicologiche dei personaggi. Le descrizioni sono vivide e evocative, restituendo al lettore l’atmosfera della Torino di fine anni ’30. Chi è alla ricerca della forma pulita e melodica, dello stile poetico evocativo del Pavese della Luna e i falò, qui non lo troverà.
Incontrerà però lo stesso Pavese che affonda nell’animo umano, vi impregna la penna e lo restituisce sulla pagina. Con tutte le sfaccettature e i simbolismi che necessita per essere espresso.
A un primo approccio la scrittura, a livello di forma, appare semplice e diretta, forse non così sofisticata come ci si potrebbe aspettare dall’autore. Un espediente che gli permette di calarsi nelle profondità dei temi trattati senza affrontarli in modo diretto, di evocare significati nascosti, non immediati. Che affiorano lenti, a poco a poco, che si svelano si fanno apprezzare solo con una lettura attenta e riflessiva. Una lettura attiva.
Tra le pagine di La bella estate – e nella vita della protagonista – aleggia un’angosciosa depressione, che richiama una certa vena autobiografica che lega pressoché tutte le opere di Cesare Pavese.
La Bella Estate, da cui nel 2023 è stato tratto il film omonimo per la regia di Laura Luchetti, è un’opera che merita di essere letta e riletta, in cui sarà possibile cogliere ogni volta nuove sfumature e significati nascosta. Una protagonista per cui è impossibile non provare empatia, un romanzo che, pur nella sua apparente semplicità, riesce a toccare corde profonde e a far riflettere sul senso della vita e sulla complessità delle relazioni umane.