Prosegue il mio viaggio alla (ri)scoperta di nomi e titoli dimenticati o a cui non è stato tributato il giusto valore. Dante Arfelli è l’autore del romanzo I superflui (Rizzoli, 1949) e nonostante abbia vinto il Premio Venezia (precursore dell’attuale Campiello) e venduto quasi un milione di copie negli Stati Uniti, oggi in Italia è pressoché sconosciuto.
Ha pubblicato poco, Arfelli, un paio di romanzi, una raccolta di racconti e un’altra di riflessioni, postuma. Aveva 28 anni quando ha pubblicato I superflui, e il Premio Venezia, del valore di mezzo milione di lire, gli era valso la fama mondiale e con essa un’iniezione di fiducia in se stesso e nelle sue competenze autoriali, proiettandolo spedito verso il secondo romanzo: La quinta generazione (Rizzoli, 1951). Poi una profonda depressione s’è impadronita di lui e lo ha accompagnato negli anni, portandolo a smettere di scrivere e a riprendere solo alla fine della sua esistenza, presso la residenza per anziani dove avrebbe terminato i suoi giorni.
Doverosa premessa per un autore che in Italia, come detto, si conosce e apprezza (troppo) poco.
I superflui è un romanzo crudo e umano, nessuno spazio a poesia o immagini edulcorate. Solo la realtà. Uno spaccato della società nell’immediato dopoguerra, in cui i giovani dovevano arrabattarsi tra le macerie del conflitto alla ricerca di un futuro.
Protagonista è Luca, un giovane provinciale che arriva a Roma tentato dalle possibilità lavorative della città. Appena giunto alla stazione, è avvicinato da Lidia, una prostituta che si rivelerà prima Mentore del suo viaggio nella società cittadina. Oltre al proprio letto, la ragazza gli offre la propria casa, che affitta da una scontrosa e anziana vedova.
Luca ha portato con sé un paio di lettere di raccomandazione con cui cerca di incontrare il favore di persone influenti in città in grado di offrirgli un lavoro, ma i risultati sono scarsi. Tramite l’intercessione dell’amico Alberto, cerca di costruirsi una rete di conoscenze che gli permetta di introdursi nell’esclusiva società dei benestanti, ma anche qui si assiste al perpetuarsi dell’idiosincrasia tra i ceti: i riccastri figli di riccastri, giovani vitelloni che frequentano le importanti università e arrivano alla laurea senza alcuna preoccupazione, e i meno abbienti che, come Luca, si arrabattano alla strenua ricerca di un impiego qualsiasi che permetta loro il minimo sostentamento.
La figura di Lidia assume gradualmente sempre più importanza nel corso del libro. Da relazione di due sconosciuti che si incontrano e passano una notte insieme – una per lavoro, l’altro per trovare accoglienza in una città sconosciuta –, la loro diventa qualcosa di più serio, un’amicizia, un cercarsi, un affidarsi l’uno all’altra, ma mai fino in fondo. Mai dichiarandolo apertamente. Perché lei è una prostituta e quest’onta di disonore la accompagna come un vestito marcescente.
Alberto, giovane rampollo di una famiglia agiata che mai ha conosciuto la povertà e che frequenta con nonchalance i migliori salotti della capitale, tratta Lidia alla stregua di una bambola da poco, che può insultare, denigrare, umiliare a proprio piacimento poiché indegna di alcuna considerazione né rispetto. Le fa scherzi pesanti, la tocca davanti a tutti, senza curarsi della sua dignità, senza considerarla una donna. Ai suoi occhi è solo una prostituta. Qualcosa di superfluo.
Lo stesso Luca cerca di frenare qualsiasi sentimento per lei pensandola come una prostituta e, in quanto tale, non una vera donna, non qualcuno con cui costruire un futuro – senza mai del tutto comprendere o accettare che la sua posizione all’interno della società è simile a quella di lei. Un superfluo, anche lui.
E questa poi non era una donna, era una prostituta, una cosa diversa.
Ragazza che rivelerà un animo generoso, ai limiti dell’amore umano. Figura pura, lieve, generosa, eppure bistrattata dai ceti sociali più alti. Che appaiono superficiali, mai in grado di concedersi un gesto sincero, spontaneo e caritatevole nei confronti di chi sta peggio. Solo offese e umilianti provocazioni.
Arfelli ritrae con sguardo lucido e inclemente un periodo, quello del dopoguerra, che può essere traslato in ogni epoca storica, con i giovani benestanti che tranquilli raggiungono traguardi inarrivabili per il ceto di Luca, inneggiando con noncuranza: “Da domani saremo nuovi disoccupati!”
Un romanzo moderno, toccante e disperato, che per temi, circostanze sociali e personaggi mi ha ricordato La bella estate di Cesare Pavese e, per il cinismo di fondo del romanzo, il distacco e l’apatia del protagonista rispetto ai fatti della vita, Lo straniero di Albert Camus.
Arfelli è un autore che non spiega le cose, le fa percepire al lettore per insinuazione. E anche in questo senso, la sua prosa è molto moderna.
Pensò ancora: lui viveva e agiva e parlava e aveva gli occhi per vedere le case, gli alberi, i giorni, un gatto, tutto ciò che esisteva fuori di lui e formava il mondo nel quale gli uomini si muovevano, il mondo che era dentro la sua testa, perché senza questa tutte quelle cose non ci sarebbero state più. Dentro quel ventre c’erano ormai una testa con i fiori, gli alberi, il cielo, il gatto; solo che colui che vi si stava formando non ne aveva coscienza, non le vedeva ancora. Era una cosa ben terribile il ventre della donna e il suo scopo, solamente ora Luca lo vedeva chiaro, non era il divertimento, ma la vita.
Un particolare interessante è che la sessualità, pur presente nel romanzo, non è mai trattata come qualcosa di gioioso o liberatorio, ma sempre con un imbarazzato disagio da parte di Luca. “Tormentato”, “angosciato”, sono gli aggettivi che Arfelli associa al momento di incontro dei sensi. Una sorta di ansia da prestazione che aleggia, che impedisce a Luca di lasciarsi andare e che esprime il senso di precarietà esistenziale, la paura di legarsi a qualcuno e il senso di colpa di concedersi qualcosa subito dopo aver sofferto i dolori le privazioni, la fame della guerra. Fame che Luca vede sempre come una possibilità, nemmeno troppo remota, all’orizzonte, e con cui tutto il ceto sociale di cui fa parte deve fare i conti, ogni giorno.
Una durezza affascinante, una prosa raffinata, di rara sensibilità.
E un encomio alla casa editrice romana Reader for blind, che ha riportato in libreria I superflui e La quinta generazioneristampandoli dopo più di settant’anni dalla prima pubblicazione.

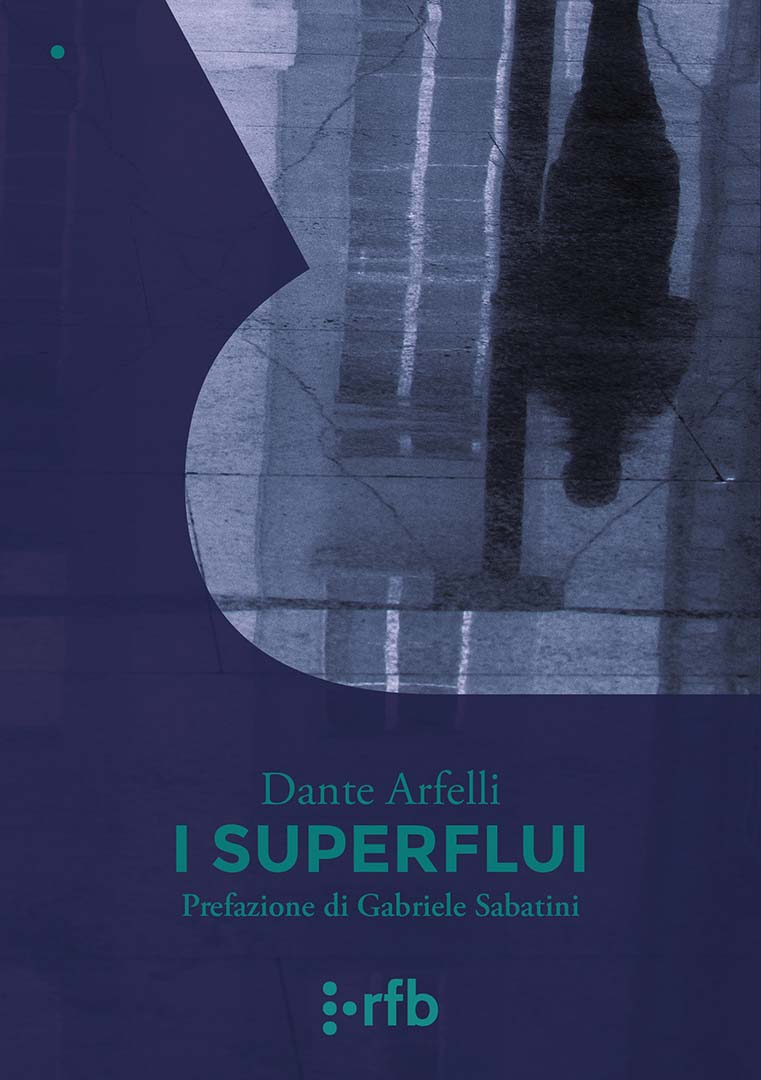



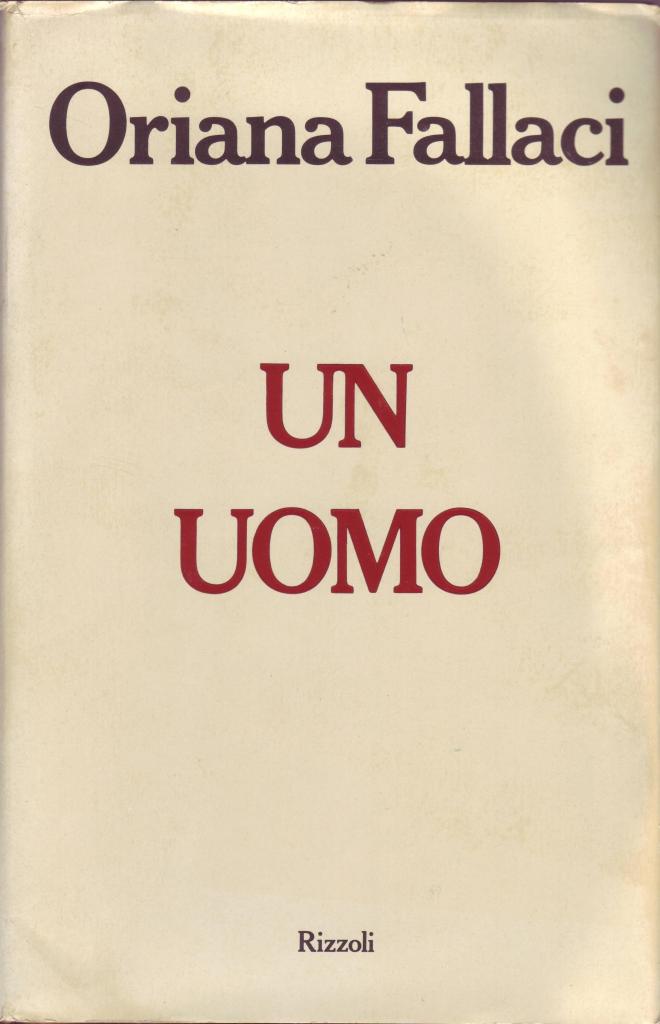
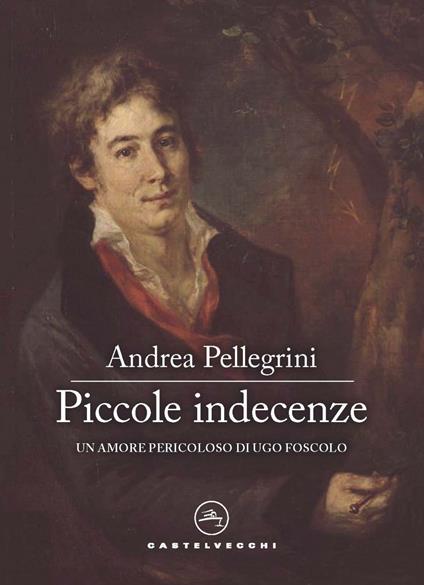







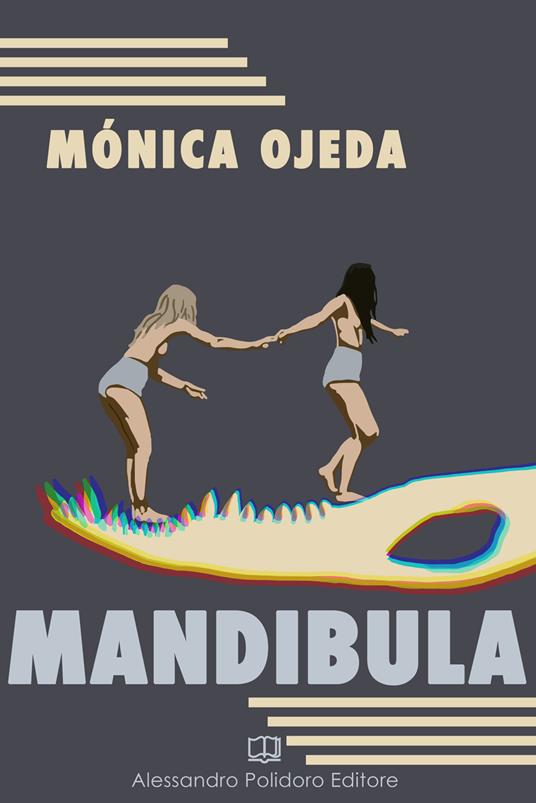




Devi effettuare l'accesso per postare un commento.