La guida definitiva alla scrittura dei dialoghi.
Che cosa si nasconde dietro al dialogo e alla sua costruzione. Come costruirne uno di valore. McKee sostiene che i grandi dialoghi sono quelli che mentre li ascolti credi di conoscere il personaggio meglio di quanto lui stesso non si conosca. La magia del dialogo, l’intuizione. E si analizzano le intenzioni non dette, il sotto testo, l’indicibile. Tutto un substrato a cui non si fa caso, quando si scrive un dialogo, e che invece ha importanza vitale. Perché è questo che infonde la vita ai personaggi e rende gli scambi credibili. È solo in presenza di tutto questo che ci sentiamo davvero davanti a persone reali, in carne ed ossa.
A sostenere la già ottima spiegazione portata con stile aggraziato e scorrevole, c’è un’encomiabile traduzione di Paolo Restuccia, attentissimo a restituire ogni particella del libro e sensibile nel conservare alcune parti in lingua originale, per facilitare la comprensione, da parte del lettore, delle indicazioni di McKee su sintassi e costruzione delle frasi.
Per gli appassionati di scrittura Dialoghi. L’arte di far parlare i personaggi nei film, in tv, nei romanzi, a teatro è una miniera d’oro, ma lo è anche per chi vuole andare oltre la superficie delle cose e comprendere ciò con cui ha, come chiunque altro, a che fare quotidianamente.
C’è un problema, però. Terminato il libro non ascolterete o leggerete più i dialoghi come facevate prima. Cercherete di andare oltre, sotto la superficie.
E non è detto che sia un male.
View all my reviews
“Una vita da direttore editoriale”, Giovanni Maria Pedrani | Recensione
Un testo per aspiranti autori e per chi voglia conoscere il mondo dell’editoria, che offre numerosi spunti, consigli e approfondimenti.
Pubblicato da Il Ciliegio (casa editrice di Giovanna Mancini sugli scaffali dal 2003), si chiama Una vita da direttore editoriale, ma il capitolo relativo a questo argomento è brevissimo e relegato, quasi con modestia, in fondo al libro.
Il testo offre invece un ampio spaccato dell’editoria in generale, con particolare riferimento alle realtà più morigerate, quelle delle piccole o medie case editrici, in cui l’autore si trova ogni giorno a svolgere il mestiere (che descrive come “il più bello del mondo”) di direttore editoriale.
Con competenza e simpatia (senza mai salire sul piedistallo della sapienza assoluta ed esclusiva che certi professionisti dell’editoria sembrano considerare loro di diritto), Pedroni conduce il lettore passo dopo passo nei meandri oscuri dei mestieri editoriali, presentandogli le varie figure che compongono quel regno: editor, grafici, correttori, revisori, stampatori, editori e, sì, anche direttori editoriali e svelando alcuni dei segreti del mercato del libro.
Una lettura leggera e agile, che consiglio soprattutto a chi desidera vedere pubblicata la propria opera ma non sa come funziona il mondo così complesso, caotico e stimolante con cui si confronta.
Amo la poesia e vorrei essere il direttore editoriale che è riuscito a trovare l’antidoto alla legge di mercato che l’ha decimata.
(G.M. Pedrani)
12.1. Come si scrivono i dialoghi
Qualcuno sostiene che scrivere i dialoghi non sia facile. Poi c’è qualcuno che mente. Parlare dei dialoghi e pretendere di esaurire la faccenda in poche righe sarebbe folle. Così come sarebbe folle in questo contesto pensare di poter trattare in maniera approfondita questo argomento, tale è la sua vastità. Come regolarsi allora? Andiamo per gradi. Iniziamo col chiarire le funzioni di una sequenza dialogica.
A che cosa serve il dialogo?
Il dialogo ha più funzioni, ma potremmo sintetizzare così:
• caratterizzare i personaggi e renderli vivi, mostrare il loro stato d’animo e offrire spunti per sottotesti;
• proseguire l’esposizione alleggerendo la prosa e spezzando il ritmo;
• far succedere le cose.
Prendiamo come spunto questo brano tratto da un racconto di Ernest Hemingway.
L’uomo stava là seduto guardando il fuoco. Quando Nick si fermò vicinissimo a lui non fece un movimento.
«Salve!» disse Nick.
L’uomo alzò lo sguardo.
«Chi t’ha fatto quell’occhio nero?» disse.
«Le ho buscate da un frenatore».
«Ti ha buttato giù̀ dal merci?»
«Sì».
«L’ho visto, quel bastardo» disse l’uomo «È passato di qui circa un’ora e mezzo fa. Camminava sopra i vagoni battendo le braccia e cantando».
«Che bastardo!»
«Sarà stato contento di avertele suonate» disse l’uomo, senza sorridere.
«Un giorno o l’altro gliele suonerò io».
«Tiragli una sassata, una volta, mentre passa» consigliò l’uomo.
«Lo farò».
«Tu sei un duro, no?»
«No» rispose Nick.
«Voi ragazzi siete tutti dei duri».
«Bisogna essere duri» disse Nick.
«È quello che dicevo».
L’uomo guardò Nick e sorrise.
(E. Hemingway, I 49 Racconti)
Grazie alla credibilità degli scambi riusciamo a recepire i movimenti dei personaggi, lo stato d’animo di Nick e la disposizione nei suoi confronti del suo interlocutore che cambia in poche battute. A un’iniziale diffidenza succede una migliore disposizione d’animo, quasi una simpatia, e il lettore lo avverte. C’è anche una certa rigidità nell’uso della lingua, che ci fa immaginare che l’interlocutore possa essere un uomo di braccia, di fatica, che non scherza molto e non dà confidenza. Però, forse, quell’occhio nero che Nick si è appena procurato lo ha intenerito, e alla fine gli sorride.
A proposito di credibilità è necessario sottolineare che il dialogo nella prosa deve ricordare il dialogo reale, ma al netto di tutti quegli elementi tipici del parlato reale – incertezze, convenevoli, ripetizioni, frasi sconnesse e interrotte – che se riprodotti porterebbero il lettore ad annoiarsi.
Il fine ultimo di una narrazione dev’essere il coinvolgimento del lettore nella storia, e questo dipende dalla credibilità di fatti, personaggi e dialoghi. Per quanto riguarda questi ultimi, la credibilità non ha nessuna relazione necessaria con la realtà. L’autore deve, ed è lì che si nasconde la vera arte del dialogo, trovare un equilibrio tra autentico e letterario. Tieni a mente che, anche se è il personaggio a parlare, è sempre il lettore a leggerlo. Non lo sta ascoltando dal vero, né c’è un attore che gli legge le battute; sta leggendo un romanzo. E il romanzo è scrittura. Deve essere piacevole, stimolante e credibile al tempo stesso.
Piccolo excursus. Mi sovviene – e ne parlo perché siamo tra amici, come in una conversazione serale davanti al camino – di una lettura[1] in cui mi sono imbattuto qualche giorno fa, che in un certo senso richiama all’inverso questo concetto. Si parlava di fiaba, e della sua origine nella tradizione orale. Le sere d’inverno, in luoghi caldi e non sempre confortevoli, i popolani si incontravano per stare insieme e passare il tempo con lavori manuali – le donne cucivano, rammendavano, gli uomini aggiustavano attrezzi – e chiacchiere. C’erano persone del popolo riconosciute come narratori che in questi contesti raccontavano le fiabe, ricordando giusto la trama ma contestualizzando le fiabe ogni volta in maniera diversa, a seconda di dove si trovavano, del pubblico, di quello che si ricordavano. Le tecniche narrative erano giocoforza diverse rispetto alle tecniche narrative usate per raccontare le stesse fiabe ai nostri giorni, perché diverso era il modo di trasmetterle. Ora sono scritte, prima narrate a voce, giocate sull’improvvisazione e sui toni. Il narratore, il più delle volte, non era istruito e riferendosi a una platea viva, rispondente in tempo reale, aveva bisogno di tecniche narrative adatte a interessare e tenere svegli gli spettatori. Si serviva perciò di figure sintattiche e retoriche tipiche del parlato: paratassi e ipotassi, ripetizioni (che servivano al narratore per prendere tempo mentre cercava altre idee, e per imprimere i concetti nella memoria di chi ascoltava), anafore, anacoluti, frasi scisse, dislocazioni a sinistra e via dicendo.
Ecco il collegamento con i dialoghi. Come la narrazione esposta oralmente non è uguale a quella scritta, i dialoghi narrativi non possono ricalcare il parlato di tutti i giorni.
La naturalezza è un’impressione, deve essere “finta” per risultare vera.
(V. Cerami, Consigli a un giovane scrittore).
Sottotesto
C’è il testo che leggiamo e il sottotesto che intuiamo. Il sottotesto è la voce interiore, che scorre sotto il piano della consapevolezza. Una superficie di testo e diversi livelli sottostanti che comprendono i pensieri nascosti dei personaggi, i desideri inconsci, i loro segreti. Proviamo a leggere il seguente brano, tratto da Underworld, di DeLillo.
«Devi dirmelo, Albert, quando esci. Così lo so».
«Ma te l’ho detto».
«Non me lo dici mai».
«Sì che te lo dico».
«Non so se è perché te lo dimentichi o se hai qualche motivo».
«Te lo dirò».
«Se me lo dici, almeno lo so».
«Te lo dirò. Farò di tutto per ricordarmelo».
«Ma io me ne dimentico, vero?»
«A volte sì».
«Tu me lo dici e io me lo dimentico, vero?»
«A volte. Non è importante».
«Però devi dirmelo».
«Lo farò, te lo assicuro».
«Così almeno lo so» disse lei.
(Underworld, D. DeLillo)
Poche righe, commoventi nella loro autenticità. La donna anziana, che perde colpi. Il marito che cerca di non farglielo pesare. Sono pochi scambi, quasi ripetitivi. Eppure si intuisce la personalità mite e accomodante dell’uno e quella appannata ma premurosa dell’altra, perché le voci sono caratterizzate in maniera esemplare e il sottotesto è ricco e vivo. Quando leggiamo i grandi dialoghi abbiamo l’impressione di avere intuizioni profonde, di entrare in contatto empatico con i personaggi, a volte ci sembra di capirli meglio di quanto loro stessi siano mai riusciti a fare. Questo è merito anche dei sottotesti, invisibili ma vivacemente presenti.
Torniamo al testo di DeLillo. Senza neppure un verbo enunciativo (se non quello sparuto “disse” alla fine) sentiamo il tono dei personaggi. Non è così?
Questo ci porta filati al prossimo argomento.
Dialogue tag
Ma sì, adoperiamo il termine in inglese. È tanto diffuso che non usarlo sarebbe un inutile snobismo. Potremmo usare il termine “didascalia” ma, insomma, ci siamo capiti.
Esistono varie scuole di pensiero. C’è chi demonizza la didascalia. Morte e insuccesso ai posteri a chi si permette di scrivere qualcosa di diverso da “disse”. Strillò, sbraitò, mormorò, banditi! In realtà basta leggere, per farsi un’idea propria. Leggere tanto. Noterai che esistono autori che non li usano e altri sì, l’ideale sarebbe trovare il giusto equilibrio.
Perché non dovresti usare “urlò” se un tuo personaggio sta urlando?
Guarda qui.
L’uomo lo prese per il bavero e lo alzò di peso dalla scrivania.
«Ma di che cazzo stai parlando, si può sapere?»
È ovvio il modo in cui lo dice, aggiungere un tag (“urlò”, “ringhiò”) sarebbe pleonastico, e rischierebbe di appesantire la lettura. Ma se all’opposto l’uomo dovesse sussurrarlo nell’orecchio del povero maltrattato, è preferibile specificarlo. Diciamo che quando il tono è intuibile sarebbe meglio evitare.
Nei casi in cui chi pronuncia la battuta potrebbe non essere chiaro al lettore, il buon vecchio “disse” è in genere la soluzione migliore. L’occhio del lettore, come il suo cervello, lo percepisce quasi come un segno di interpunzione, serve solo a specificare chi sta parlando in quel momento.
Non puoi (e non devi) eliminare tutti i tag, solo usali con parsimonia, e con la consapevolezza che stai appesantendo il dialogo, impedendo, o comunque ostacolando, una delle sue funzioni primarie, che è proprio quella di alleggerire la prosa.
Il modo di parlare dovrebbe variare per ogni personaggio.
Ogni personaggio dovrebbe parlare con la sua voce. Ogni voce deve essere costruita dall’autore in maniera consapevole, e distintiva di ciascun personaggio. Se il personaggio è ben costruito avrà una storia, che comporterà un ceto di origine, situazione vissute, un’istruzione che a sua volta comporterà un vocabolario, una scelta lessicale; avrà, se è ben costruito, un carattere, dei desideri, degli obiettivi, delle preferenze. “La sua voce sarà la naturale conseguenza della sua personalità unica, delle sue esperienze, delle sue conoscenze, del suo modo di parlare e del suo accento” (R. McKee, Dialoghi).
Il rischio per l’autore inesperto è di elaborare un proprio stile e fare parlare tutti i personaggi allo stesso modo, comportando una piattezza di fondo che limita le potenzialità della storia.
Per oggi ci fermiamo qui. Nella seconda parte del post parleremo di come far parlare i personaggi, di come rendere realistici i dialoghi in un romanzo fantasy o storico e di quali sono gli errori più comuni che riscontro nei romanzi di esordienti o aspiranti autori.
Alla prossima, quindi, e… buona scrittura!
[1] La fiaba di tradizione orale, A. Guaita (in Ellin Selae, n.146)
“Lo straniero”, Albert Camus | Recensione
A colpire è la distanza che il protagonista pone fra se stesso e ciò che vive quotidianamente. Uno spettatore apatico e estraneo alla propria vita. Straniero, appunto. L’incipit, entrato nella storia, dà subito la cifra del romanzo e il coinvolgimento del narratore in ciò che narra. Narrazione in prima persona, auto dialogica, ma per la distanza che Meursault tiene dalla storia sembra quasi non appartenergli. Si lascia trascinare. Dai personaggi che la animano e che lui segue con passività. Dalle donne. Una trama ineluttabile con la quale non vuole interferire. La morte capita a tutti, così come la giustizia farà sempre il suo corso. E lui, spettatore indifferente, segue lo sciorinarsi della matassa della sua stessa esistenza con il minor coinvolgimento possibile, quasi annoiato del protrarsi di alcune vicende. Come quando commenta l’atto processuale in corso ai suoi danni.
In realtà non mi dispiaceva poi molto di ciò che avevo fatto. Non capivo il perché di tanto accanimento.
Una distanza siderale, uno straniamento che si traduce in noia e ricorda i blocchi dietro i quali ognuno di noi, in certi periodi della vita, preferisce nascondersi, piuttosto che dover affrontare decisioni, o farsi carico di responsabilità o dolori troppo gravosi per essere sopportati.
Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall’ospizio: “Madre deceduta. Funerali domani. Distinti saluti.” Questo non dice nulla: è stato forse ieri.
Il tormentone “non significa nulla” è una pietra che il protagonista pone tra sé e il mondo. Un modo per astrarsi dalle prove quotidiane, dalle più semplici alle più difficili da affrontare. Come la richiesta della fidanzata Maria di una conferma del suo amore, a cui non riesce a dare soddisfazione arroccato in un costrutto di esistenziale per cui la vita non va vissuta ma semplicemente sfiorata.
Un momento dopo mi ha domandato se l’amavo. Le ho risposto che era una cosa che non significava nulla, ma che mi pareva di no.
Non conosciamo le motivazioni, vediamo solo il risultato finale di una scelta. Tornano alla mente le parole usate dal narratore in L’amore fatale, di Ian McEwan, che forse avrebbero descritto il protagonista di Lo Straniero, pressappoco così:
Come il personaggio di un sogno, vive al tempo stesso in prima e in terza persona. E come in un sogno le sue reazioni emotive sono inesistenti o inadeguate.
Il suo modo di guardare la vita, nulla significa, la morte di sua madre. Una donna che lo ama e che vuole sposarlo. Tanto da trovarsi ad uccidere un uomo come fare una passeggiata.
A questo si affianca la prosa evocativa, profonda e coinvolgente di Camus. Chi legge segue la narrazione con il fiato sospeso, provando le emozioni di cui il protagonista difetta e vivendo le reazioni che comprime dentro di sé, fino alla fine del romanzo, quando rimbrottato dal commissario prima e dal prete dopo, proprio per questa mancanza di umanità e di presenza nei fatti, esplode in un grande e liberatorio sfogo. In poche pagine una pietra miliare.
L’amore ai tempi del clockpunk – Intervista a Giuseppe Chiodi, autore del romanzo “Il mistero del principe”
In occasione della recente uscita del suo romanzo Il mistero del principe, scambiamo quattro chiacchiere con Giuseppe Chiodi, scrittore e autore anche di un fortunato blog, pieno di spunti stimolanti.
Stimoli fuori dall’ordinario anche per il tuo romanzo, che mostra interessanti tratti clockpunk. Innanzitutto ti chiedo di spiegarci cosa si intende in generale con questo termine.
Un’opera clockpunk presenta una tecnologia meccanica retrofuturistica. Si tratta di un sottogenere dello steampunk, a sua volta partorito dalla fantascienza e, in certi casi, dal fantasy. Le storie steampunk sono ambientate, in genere, in un’epoca vittoriana alternativa e fanno sfoggio di macchinari a vapore a dir poco ipertrofici. Ecco, il clockpunk funziona allo stesso modo, ma la tecnologia di riferimento esplode nel Rinascimento e raggiunge la massima espressione a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento. È quella degli orologi, degli automi, dei carillon e di certi giocattoli a molla.
In che cosa il tuo romanzo si può definire appartenente al genere?
La trama de Il mistero del principe ruota intorno a un prodigio fantascientifico immaginato nel Sette-Ottocento. Il romanzo è, inoltre, ricco di meraviglie retrofuturistiche di quell’epoca, realmente esistite o millantate… ma non voglio fare spoiler!
Evitare lo spoiler è doveroso parlando di un romanzo pieno di mistero come il tuo, perciò mi guarderò bene da farti domande inerenti la trama.
Nel testo di presentazione del romanzo si legge: “A volte il dolore è insopportabile e rischiamo di perderci. A volte è sufficiente una luce per ritrovare la strada, voltare pagina e rinascere”. È davvero così?
È così. L’ho vissuto sulla mia pelle e visto coi miei occhi. Non è sempre sufficiente, come dimostra un certo personaggio della storia, ma in certi casi sì. Non giudico chi rinuncia a riprendere in mano la sua vita, anzi; non escludo di comportarmi esattamente in questo modo, semmai il mondo mi crollasse addosso. Ma quella luce esiste e può diradare le tenebre più fitte.
Può bastare una luce metaforica a voltare pagina, o è più un monito, un proposito che vorresti infondere nel tuo lettore?
La luce di cui parlo non è solo un monito. Ne parli tu stesso nella domanda successiva. Vorrei che il lettore capisse che si può sempre andare avanti, et ventis adversis. Ma non solo. Tante persone hanno paura di fidarsi davvero del partner; di concedersi, di rinunciare alla propria individualità e sicurezza, di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ebbene, Il mistero del principe è il mio tentativo di spiegare perché questo è un errore.
Mi colpisce, nel tuo romanzo, l’amore. Inaspettato, il gesto dell’amore. Nell’amore. Non so se te ne sia accorto scrivendolo ma tra robot e palingenesi, l’amore si percepisce, incombente. Amore per la scoperta, per la storia, per una persona con cui ci si completa o per il padre, nel caso della protagonista femminile Eulalie, e amore per la tua città, Napoli. Contorto, a volte, non lineare e ostacolato, ma pur sempre amore. Sembra che tutto quanto ciò che si muove nel libro ne sia permeato, o alla sua ricerca. C’è del vero in quest’affermazione?
Ho scritto il romanzo con due Temi fissi nella mente: Amore e Rinascita. Il duo (anzi, il trittico, dal momento che la Rinascita include la Morte) è collegato dalla seguente premessa narrativa, o punto di vista tematico: «l’Amore conduce a una Rinascita». Il libro è, in effetti, permeato dai suddetti elementi, poiché ho scritto ogni singola scena in modo tale che soddisfacesse la premessa narrativa e facesse emergere i Temi. Quindi… sì, c’è del vero nella tua affermazione e sono contento che te ne sia accorto. Significa che ho lavorato bene!
Quanto per te è importante quest’astrazione?
Tanto, sia come persona che come autore. Ho avuto molte passioni nella mia vita, per attività e persone, e ognuna di queste mi ha spinto a rialzarmi e a crescere. Si può dire che ognuno di noi abbia avuto tante vite; tante quante le cose che abbiamo amato.
Qual è stata la più grande difficoltà nello scrivere Il mistero del principe?
Finii di scrivere il romanzo nel 2017, editing incluso… ed era molto, molto diverso da come si presenta adesso! Ci ho lavorato negli anni successivi, ma in modo discontinuo fino al 2019-2020 (nel frattempo ho scritto un altro romanzo).
Ma qual è stata la più grande difficoltà? Bella domanda. È stato difficile far quadrare tutto, dal punto di vista della trama e dei personaggi. Col protagonista, in particolare, ho battagliato parecchie volte. Pasquale ha avuto varie identità, a pensarci, tutte simili tra loro ma per nulla uguali.
Quanto c’è di autobiografico?
Tanto e poco. I romanzi sono, spesso, delle rielaborazioni del vissuto dell’autore. Ci sono elementi di vita vera, certo, ma trasformati, fusi a momenti inventati e impossibili da isolare. In genere, comunque, condivido l’idea di Jack London secondo cui
Devi scordarti di te stesso. E allora il mondo si ricorderà di te. Ma se non ti danni e non ti scordi di te stesso, allora il mondo si turerà le orecchie per non sentirti. Riversati tutto nel tuo lavoro fino a che il tuo lavoro non diventi te stesso, senza però che ti si veda da nessuna parte. Quando, nel Riflusso della marea, la goletta arriva all’isola delle perle, e il pescatore di perle incontra i tre disperati e oppone la sua volontà alla loro per la vita e per la morte, il lettore pensa forse a Stevenson? Rivolge forse anche un solo pensiero all’autore? No, certo che no. Dopo, quando tutto è finito, egli ricorda, e si meraviglia, e ammira infinitamente Stevenson; ma in quel momento? Neanche per sogno.
(Pronto soccorso per scrittori esordienti, J. London).
Quanto secondo te le serie tv, videogiochi, le produzioni audiovisive influenzano ai giorni nostri la letteratura?
Tanto e poco. È un’influenza discontinua, eterogenea. Non c’è dubbio che, almeno in Italia, i vari media abbiano un grosso impatto su una certa letteratura di genere, ma il mondo videoludico è ancora visto con scetticismo da tante persone. È un peccato, perché alcune delle migliori storie che abbia mai “vissuto” mi sono state trasmesse proprio dai videogiochi!
E i dialoghi?
Quante volte leggiamo dialoghi, in determinati romanzi, che sembrano essere tratti da film? E non lo dico come complimento. Mi riferisco a quella matassa di gergo, stereotipi, frasi fatte, citazionismo, frasi a effetto e chi più ne ha più ne metta che piagano il mondo del cinema e delle serie. Certi autori le riproducono fedelmente, incluse di adattamento improbabile da doppiaggio. “Ehi, campione!”.
Il cosiddetto doppiaggese, lo conosco bene. Leggendo per lavoro manoscritti di aspiranti scrittori capita spesso di incontrare esempi simili, ma a volte l’autore è aperto e recepisce i consigli dell’editor.
Affrontiamo ora altri due temi: arte e mercato. Quanto pesa il mercato rispetto all’arte?
Non voglio sconfinare in campi di cui non capisco una cippa, quindi… continuiamo a parlare di libri. Non c’è molto da dire a riguardo, purtroppo: in Italia è praticamente impossibile vivere di scrittura, indipendentemente dal target che si insegue. Certo, ci sono prodotti più popolari di altri e un pubblico può essere di gran lunga più redditizio di un altro, ma neanche il Dan Brown di turno riuscirebbe ad arricchirsi in questo modo. Il libro non può essere l’attività principale; deve essere trainato. E poi, per quanto si possa essere furbi e consci del mercato, in Italia continua a contare di più il familismo. Insomma, dipende tutto da chi conosci, e non è una frase fatta. Per niente.
Ti è mai capitato di scrivere pensando di indirizzare il tuo scritto verso le tendenze del mercato, di privilegiare la vendibilità a un’idea che sentivi personale?
Cerco di coniugare le due cose. Uno spunto che mi stuzzica, un argomento di cui mi preme parlare… e un’idea in grado di attirare potenziali lettori. Ma è un esercizio che non comprende calcoli, ritorno di investimenti o cose del genere: ‘mercato’ e ‘vendibilità’ sono paroloni in questo campo.
Come mai la scelta del self publishing?
Conosco bene pro e contro della scelta, poiché autopubblicai nel 2013-2014. Nel frattempo sono approdato alle case editrici, ma ho rifiutato varie proposte per Il mistero del principe. Ritengo che l’autopubblicazione sia più appropriata per quest’opera e per il progetto personale che c’è dietro. Un progetto in lenta e inarrestabile espansione…
E ci vuoi anticipare qualcosa di questo progetto?
No!
In che cosa la senti più appropriata e in che cosa non ti convinceva la collaborazione con case editrici?
È un discorso molto complesso, ma vedrò di farla breve. Le case editrici sono tutte diverse, e così i contratti di pubblicazione che offrono… ma il range di parametri non è così ampio, in media. Le royalty sono basse (molto più basse rispetto al self, per ovvi motivi), la promozione è spesso poco efficace e i diritti possono restare nelle mani della CE per tanto tempo (qualcuno mi propose di cederli per venti anni. Non firmate robe del genere, vi prego). Ma non è questo il motivo per cui ho deciso di autopubblicare Il mistero del principe, no. È la libertà. Ogni CE ha le sue norme redazionali a cui occorre attenersi. Il romanzo non sarebbe mai stato impreziosito dagli extra, le immagini ecc. che ho elaborato per esso, se fosse stato pubblicato da una CE. Né avrebbe avuto la formattazione giusta.
Hai un blog avviatissimo in cui presenti anche lezioni di scrittura creativa. Quanto ritieni importante la ‘scuola’ per un narratore rispetto, per dire, al talento?
Bella domanda! Chi mi legge saprà come la penso: la ‘scuola’ è tutto, a mio avviso. Credo al talento, o alla propensione, ma in misura minore rispetto allo studio e al duro lavoro. Il talento, ammesso che esista, va coltivato, o cessa di esistere. Non resta con noi per sempre.
Folklore e leggende. Mi sembra di capire che nutri un profondo interesse per il folklore, soprattutto quando si mescola alla leggenda, alla superstizione. Le credenze popolari tanto diffuse in tutta Italia, di mostri e fantasmi e streghe. Ho visto che hai scritto diversi testi al riguardo. Parlaci delle tue influenze e delle tue passioni.
Amo girare per l’Italia e scoprire le infinite credenze, favole e leggende che animano la nostra penisola. L’italiano medio non ha idea di quanti mostri, eroi, dei, fantasmi e così via abitino nei dintorni della sua casetta: è un tesoro ricchissimo, una fonte d’ispirazione inesauribile. Da Napoli a Torino, dalle Eolie alla Carnia, non basterebbe una vita per vedere tutte le meraviglie e assorbire tutte le storie che permeano il Bel Paese.
Così su due piedi: la storia, la leggenda che preferisci, quella che ti ha colpito di più, quella magari più curiosa, o semplicemente quella che ti è rimasta più impressa?
Difficile scegliere la più curiosa su due piedi. Vediamo… di sicuro, una sfiziosa è quella del drago di Atessa, un comune del Chietino. Secondo la leggenda, La Tessa (così era chiamata) si formò dall’unione di due città, Ate e Tixia, separate da una palude in cui abitava un drago sputafuoco. Be’, San Leucio uccise il drago e gli strappò un’enorme costola, tuttora conservata nel Duomo della città. La si può ammirare in una teca.
Cosa ti stimola?
Viaggi per l’Irpinia e t’imbatti nel laghetto della Mefite: un pantano sulfureo unico al mondo, un micro-paesaggio lunare battezzato col nome di una Dea dimenticata. Ne parla anche Virgilio, ma… se non lo sai e ignori i cartelli di pericolo, la curiosità potrebbe ucciderti.
Viaggi nel Senese e t’imbatti in un mare di dune sabbiose e calanchi: è il deserto di Accona. Capiti da quelle parti in primavera? Il deserto si tramuta in una valle paradisiaca, una contea tolkieniana punteggiata dai cipressi.
E mi chiedi cosa mi stimola?
Da cosa nascono queste passioni?
La domanda è: da cosa non nascono. Dovremmo prestare più attenzione alla terra che calpestiamo, all’aria che respiriamo, ai nomi che portiamo. Non siamo nullità; è quello che ho cercato di far capire col romanzo che ho pubblicato nel 2018, Cuore di Tufo.
Da dove sei partito e dove sei arrivato, nel tuo percorso?
Sono partito nel 2009-2010. Appena finita la scuola, insomma. Terminai di scrivere il mio primo romanzo giusto dieci anni fa, nel 2011. Era una schifezza; quanta acqua è passata sotto i ponti! Mi accingo a scrivere il mio sesto romanzo, da allora, eppure ho ancora così tanto da imparare. Sono cresciuto e mi ritengo una persona preparata in fatto di storie, ma credo di essere ancora molto lontano dalla meta. Non voglio diventare uno scrittore ricco sfondato; la vita non è un fantasy. Ma uno scrittore eccezionale sì. Voglio arrivarci, lotterò per arrivarci, e se non ce la farò… ne sarà valsa ugualmente la pena.
E a che punto del viaggio sei?
Sto giocando, in questi giorni, a un roguelike chiamato Skul, the hero slayer. In questo gioco, l’eroe può trovare un gran numero di teschi da equipaggiare, ognuno con le proprie mosse, statistiche e livello di rarità. Ogni teschio può, comunque, essere portato alla rarità massima con l’uso di alcune ossa. Le rarità sono: common, rare, unique e legendary. Ecco, se dovessi usare questa come scala, direi di essere passato da common a rare. Il difficile viene adesso, ma… non aspetto altro!
Intervista di Francesco Montonati
“La città dei vivi”, di Nicola Lagioia | Recensione
Qualcuno l’ha paragonato ad A sangue freddo di Truman Capote. Un racconto che immerge nel degrado umano, nella perdita di valori di una progettualità vaga e infattibile. Fuori dal reale, compromessa. Ma si può davvero parlare di ‘romanzo’?
Iniziamo col dire perché non è accostabile al romanzo di Truman Capote. Il primo è un romanzo interiorizzato, che cerca di empatizzare, per quanto possibile, con i criminali, Capote ha passato moltissimo tempo con uno di loro, lo andava a trovare in carcere, lo intervistava, era totalmente immerso e divorato dal suo stesso romanzo. La città dei vivi è invece un reportage che usa la focalizzazione esterna, distante dal fatto e dai personaggi. Gli accadimenti sono narrati in terza persona e l’autore-narratore non si azzarda per un attimo a far suoi i pensieri degli assassini, li scruta, li esamina a fondo, ma sempre dietro il vetro del parere personale esterno. Per questo fa uso di una narrazione distaccata, giornalistica, non asettica – questo no – ma molto sulle sue, che non si prende il rischio di avvicinarsi troppo al fuoco di cui sta raccontando l’abbrivo e il propagarsi. Un episodio di cronaca nera di qualche anno fa, marzo 2016: il ventitreenne Luca Varani – ragazzo tranquillo, un lavoro in carrozzeria, una fidanzata storica – è ucciso da due ragazzi della medio-borghesia romana, che privi di passioni o interessi, trascorrono giornate e nottate a sniffare cocaina, ubriacarsi e, in questo caso, uccidere senza motivo. Perché in effetti non c’è motivo.
Lagioia in questo reportage tenta di spiegar(se)ne le cause ma mai di immedesimarsi, di carpirne i pregressi, i vissuti che hanno portato i due mettere in atto un gesto così cruento (il ragazzo è stato torturato per ore, prima di morire dissanguato), ma invece che esaminare le cause dal dentro, sempre dal di fuori, alla disperata ricerca di un particolare, un momento, un movente che lo avvicinasse alla vicenda. La sensazione è che Lagioia tentasse di comprendere l’efferato gesto, gli assassini, utilizzando la sua vita e i suoi vissuti come metro di giudizio.
Come se una persona normale cercasse di capire un assassino non cercando di entrare nella mente dell’assassino, nel suo passato, nei suoi pensieri, nelle sue urgenze ecc. ma valutando questi aspetti con la lente della propria vita. Anch’io, dice, ho guidato da ubriaco e stavo per ammazzare qualcuno. Mi è andata bene, a me. A loro no. L’obiettivo di Lagioia sembra essere trovare una spiegazione a questo efferato omicidio, perché in qualche maniera lo sente vicino, si sente ossessionato da questo episodio di cronaca. La sensazione è proprio questa: si evince il suo desiderio, la curiosità di entrare nel fatto (il fascino del male) ma senza averne fino in fondo il coraggio, mantenendo sempre una distanza di sicurezza, uno scudo trasparente che permetta di vedere il male ma difenda dai suoi artigli. Il problema è che senza gettare lo scudo è impossibile penetrare fino in fondo in quel sottosuolo di dostoevskiana memoria. Esisterà sempre una distanza, di sicurezza appunto. Ed è questa la più grande differenza tra il capolavoro di Capote e il reportage di Lagioia. Capote lo scudo non lo ha nemmeno preso in mano. Si è gettato a capofitto, narrando la storia usando la focalizzazione interna. Il soggetto percipiente non è la vittima ma il carnefice. Un carnefice non fiction ma in carne e ossa, vivo (almeno fino alla sedia elettrica) e agente in Terra del male. Lo guarda negli occhi e lo sfida e vi entra dentro, indossandoli quegli occhi.
La narrazione di per sé è funzionale all’argomento trattato, non si eccede mai in melodrammi o in enfatici quanto ovvi giudizi. La lettura procede fluida, lo stile narrativo è quasi sempre fruibile, il registro linguistico semplice, divulgativo, di qualcuno che vuole farsi ascoltare – a differenza di quello usato in “Ferocia”, vincitore del Premio Strega 2015, il cui era aulico, volutamente farraginoso, urticante, pleonastico e autocompiaciuto.
La città dei vivi è un libro che chi ama il genere cronaca nera (i programmi di Franca Leosini, Roberta Petrelluzzi, Carlo Lucarelli e compagnia bella – come me, peraltro) apprezzerà di certo. Un reportage, un’inchiesta molto psicologica, se mi si passa il termine, ma non un romanzo. Segue la struttura del romanzo, ci sono inserti che portano avanti la storia e, sì, sono seminate esche narrative e metonimie, e tutto concorre a stabilire una tensione narrativa, ma per definirlo romanzo bisognerebbe che avvenissero cose, che ci fosse una fabula, mentre qui si tratta più di un patchwork di interviste, deposizioni, pareri, accadimenti, che seguono sì una linearità cronologica ma non ne fanno un romanzo.
“Orca”, di Arthur Herzog III | Recensione
Qualcuno avrà visto il film L’orca assassina, un film del 1977 con Richard Harris e Charlotte Rampling, ma pochi conoscono il libro. Il nucleo del romanzo non è la lotta dell’uomo contro la natura come ne Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, ma – come in Moby Dick di Herman Melville – un animale, figlio della natura, caricato dall’uomo di valore negativo, personificazione del male di una vita.
Pur risentendo con evidenza della lezione dei due maestri, il libro non raggiunge le vette dei romanzi citati, né vi si avvicina. Lo stile non ha guizzi o una personalità memorabile, i personaggi potevano essere meglio costruiti e i dialoghi sono spesso forzati, anche se credo che ciò sia imputabile alla (datata) traduzione italiana che tende a edulcorare le espressioni colorite anche quando, trattando di pescatori e uomini del popolo, questa tendenza andrebbe evitata. A parte questo, il romanzo non è sgradevole, tutt’altro. È ben strutturato e piuttosto avvincente.
A me è piaciuto e mi sono piaciute le interazioni fra i personaggi, anche se le situazioni, in alcuni momenti, erano descritte attraverso uno sguardo molto (forse troppo) cinematografico, quasi a voler suggerire l’utilizzo del romanzo in tal senso (come poi è stato fatto).
Un romanzo onesto e, pur senza guizzi, piacevole, che mi sento di consigliare.
“Guerra e pace”, di Lev Tolstoj | Recensione
Leggere Guerra e pace è come vivere un’altra, ulteriore vita oltre alla propria, per la quantità e la varietà degli spunti di riflessione che offre. Recensire un tale capolavoro in termini di profondità e struttura è un’impresa al di fuori delle capacità umane. Vi dirò quello che ho sentito, che ho provato. Mi limiterò a questo.
Guerra e pace è un romanzo di quasi milletrecento pagine, dense e pulsanti. Territori di guerra, entrarci e camminare; marciare con loro, i soldati dell’armata russa. I cosacchi apparire di lontano, alle spalle, fra pallottole e palle di cannone che fischiano vicino agli orecchi, e tu, con il tuo cavallo, a correre verso di loro, gli artiglieri dell’armata napoleonica, con le divise turchesi, il sangue ovunque. Inaspettata, l’allegria ti pervade, un senso di appartenenza, mentre generali intontiti dagli anni si addormentano ai consigli di guerra e con noncuranza mandano giovani al macello. E l’ansia che si tramuta in esaltazione, e i sotterfugi e gli inganni fra i colpi d’arma da fuoco e lo scalpito dei cavalli e la neve che avvolge e ghiaccia i piedi e copre le pianure e senza cibo a combattere senza sapere il perché. La desolazione di una Mosca conquistata e saccheggiata. Una guerra di masse che si scontrano, in unità compatte prima e disgregate poi. Una guerra provocata da qualcosa e da qualcos’altro e sempre da qualcos’altro, una guerra a cui niente e nessuno si sarebbe potuto opporre, perché ineluttabile nella molteplicità degli eventi che l’hanno provocata.
Si perdoneranno i momenti filosofici lunghi e prolissi, di fronte a uno scenario emotivo, descrittivo e narrativo così vasto e inarrivabile.
Quelle di Guerra e pace sono pagine immortali di letteratura, in grado di cambiare i connotati del sistema primo e originario del lettore che si cimenti nella lettura, le sue convinzioni e il suo modo di vedere il mondo. Assoluto capolavoro.
“It”, Stephen King | Recensione
Sette ragazzi uniti contro il male. Una storia che corre avanti e indietro tra due epoche e tra due età. Passato e presente, infanzia ed età adulta. C’è un clown, che semina il terrore e uccide il piccolo George, della cui morte suo fratello maggiore Bill si sentirà per sempre responsabile. Sullo schermo l’abbiamo visto milioni di volte, ma il clown non è che la punta di uno sterminato iceberg.
Dopo il primo atto di presentazione dei personaggi principali e del contesto – sono molti, e l’autore si prende il giusto tempo – la narrazione si sviluppa su due epoche storiche in cui avvenimenti simili avanzano parallelamente. Il momento presente, il 1985, quando i protagonisti tornano alla città natale per sconfiggere definitivamente il mostro, e 27 anni prima, quando il mostro l’avevano già bell’e rispedito nelle fogne, nelle quali sembra vivere e nascondersi. Se fosse tornato, anche loro sarebbero tornati per chiudere i conti con lui; questo il patto con cui si erano lasciati nel 1958.
King costruisce un’ambientazione oltremodo caratterizzata – Derry – prendendo spunto da Bangor, la cittadina nel Maine dove ha vissuto la propria infanzia. È tutto definito, dal nome delle vie alla geografia locale, all’assetto urbanistico; i Barren, la cisterna e via dicendo. Scenario realistico, fin troppo dettagliato.
Uno dei difetti maggiori del libro è la profusione di informazioni di cui è inondato il lettore. Quando riguardano i personaggi o l’azione degli stessi, i dati forniti sono funzionali alla narrazione, ma quando l’autore si perde in descrizioni di personaggi secondari, ambienti non direttamente collegati alla storia, la tensione narrativa si spegne e viene voglia di saltare alcune parti. Questo tipo di lungaggini rallentano la lettura. È una caratteristica propria dello stile narrativo di Stephen King. Neanche venisse pagato a parola, l’autore ha spesso la tendenza a infarcire le sue storie con eventi paralleli fini a se stessi e a perdersi in descrizioni lunghe e particolareggiate di situazioni e fatti limitrofi all’azione principale, che se da una parte ritardano i colpi di scena, dall’altra influiscono poco o niente sulla storia e rallentano la lettura.
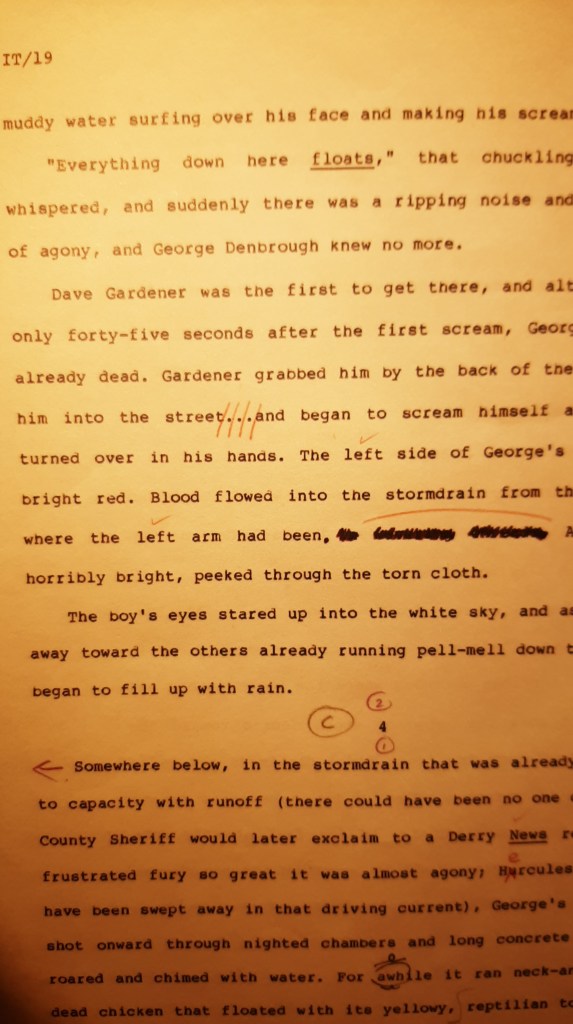
La narrazione, caratterizzata dai salti temporali di cui si è parlato, è uno dei punti di forza del romanzo, uno dei tratti che maggiormente lo caratterizza. Elemento che però, proprio a causa della sua forte tipicità, rischia di avere un esito diverso o contrario a quello desiderato. Spieghiamo. Il racconto, come detto, si dipana in un continuo rimbalzo avanti e indietro tra due epoche, l’età fanciullesca dei ragazzi, quella dei giochi e delle scaramucce, e l’età adulta, fatta di pesi e responsabilità finali, definitive. In una narrazione del genere, il rischio di inficiare il patto implicito con il lettore si corre, perché ogni volta che si è sottoposti – come lettori – a un brusco passaggio temporale, una scintilla mentale si stacca dal racconto per pensare al meccanismo narrativo usato, alla prolessi, all’analessi, e al preciso obiettivo dell’autore, quello cioè di fare combaciare episodi simili in due epoche diverse e di farli emergere filtrati dalla percezione dei personaggi. Prima una visione infantile, aperta a esperienze improbabili, alla possibilità dell’assurdo e dell’irrazionale, poi lo stesso episodio vissuto da adulti, in un disperato tentativo di razionalità e con il pensiero rivolto alle conseguenze dei propri gesti – pensiero che, da bambini, era quasi del tutto inesistente.
Ma non stiamo parlando di un autore alle prime armi o che muove passi malfermi nel territorio vago e opaco della scrittura. Stephen King ha spalle robuste e una grande esperienza. E non fallisce.
È a questo punto che la maestria dell’autore deflagra in tutta la sua potenza. Il pregio maggiore del romanzo sta nella sua evoluzione metaforica, simbolica e surreale. Tutti abbiamo in mente Pennywise, il pagliaccio cattivo che offre il palloncino al bimbetto George da dentro il tombino. Abbiamo in mente quell’immagine perché ciò che rappresenta davvero quel pagliaccio – il suo valore astratto contrapposto alla sua manifestazione terrena, il suo ritorcersi nella sua stessa, incoerente e del tutto umana paura, il suo esistere in bilico tra sogno, realtà, pensiero, suggestione condivisa –, ciò che rappresenta davvero quel clown, dicevamo, non è possibile afferrarlo, comprenderlo a pieno, se non leggendo il libro. A tratti il linguaggio si fa fluido e scorre senza attriti in una sapiente alternanza tra discorso diretto e indiretto libero (ne parlo qui), in uno stream of consciousness degno del James Joyce più ispirato. Un climax che è opera finale, che vale il libro. È come se dopo tutta quella narrazione di fatti, di cose, di luoghi e di eventi, King appoggiasse la penna e dicesse, ok, a letto i bambini; adesso facciamo gli scrittori, quelli con la L (di literacy) maiuscola. E si addentrasse nel profondo, nell’assoluto.
È necessario che vengano convinti con le parole, convinti ad accettare questo fondamentale legame umano tra il mondo e l’infinito, unico luogo in cui il fluire del sangue umano tocca l’eternità. Non importa. L’unica cosa che è importa sono amore e desiderio. Qui in questo buio intenso va benissimo, meglio che in molti altri posti, probabilmente.
L’episodio più controverso del romanzo (allarme spoiler, se non hai ancora letto il libro, regolati di conseguenza!): sei ragazzi di undici anni consumano a turno un rapporto sessuale con la loro coetanea e amica Beverly. King spiega così l’episodio: «Per i maschi del club dei Perdenti, Beverly diventa il tramite simbolico del passaggio tra maturità e infanzia. È un ruolo che le donne hanno rivestito molte volte nella vita dei ragazzi: l’arrivo simbolico dell’età adulta segnato dall’atto sessuale».
Ma King – ed ecco la sua maestria – non fa cadere a caso l’episodio. Che ha luogo infatti verso la fine del romanzo, quando in questo ripetersi di avanti e indietro si è arrivati contemporaneamente alla fase finale delle due epoche: dell’85 da una parte e del ’58 dall’altra, fase quest’ultima che sancisce il passaggio dei protagonisti dall’età infantile a quella adulta. Ormai conosciamo i personaggi, i sentimenti che li alimentano, il senso di appartenenza al gruppo che li lega, l’affetto reciproco e l’ansia condivisa che li consuma. Un episodio sicuramente intenso ma che non è messo lì per stupire o per scioccare, come alcuni lettori hanno avuto modo di obiettare (una gang bang di undicenni, ho letto da qualche parte). Il significato di quel momento trascende il tangibile. Il simbolico dell’atto è impalpabile, è astrazione, è un evento mentale e istintuale la cui risonanza sul piano reale non viene affatto sottovalutata dall’autore, il quale mette anzi il lettore (dotato di sensibilità e di proprio senso critico) nella posizione di non recepirlo come abominio inverosimile ma come plausibile – sia pur remota – eventualità (del resto, quante volte ci è capitato di vedere il male tramutarsi in un clown con zanne da squalo e offrire palloncini dai tombini?). La ragazzina si offre spontaneamente – è anzi lei a convincere i più reticenti fra i suoi amici – perché capisce che è la cosa giusta da fare in quella circostanza, per chiudere il cerchio con lei al centro, per contrapporre il suo amore – desiderio e amore e buio – al male di It, che è a sua volta un essere femminile, e come tale nativo e fecondo. L’unico modo per respingerlo e rimanere in vita. Bisogna essere dotati di un talento fuori dal comune per compiere una magia simile (o di tecnica, giacché alcuni detrattori di King sostengono che non abbia alcun talento), e King ci riesce.
Per concludere, It è un horror che ha i connotati del romanzo di formazione, ideale estensione del racconto The body da cui il celeberrimo (e bellissimo) film Stand by me. Appassionante e con un finale poderoso e intenso, indaga il periodo di transizione dall’età infantile all’età adulta, riconoscendo infine l’innato bisogno dell’essere umano di ricongiungersi, una volta adulto, con l’età dell’infanzia, trovando nella chiusura di quel cerchio la completezza del suo essere.
Grande prova di valore e maturità autoriale. Non provateci a casa.
Recensione di Francesco Montonati
“Lascia un libro, prendi un libro”, la biblioteca diffusa per tutta l’Italia – Intervista a Giuseppe Rapisarda
Hai presente il libro che ti ha regalato zia Matilde e che – prima o poi lo leggo, prima o poi lo leggo – alla fine non leggi mai? Ecco. Non lo leggerai, mai. Te lo dico io. Resterà lì a prendere polvere. Meglio scambiarlo con un altro libro, magari più vicino ai tuoi gusti. Zia Matilde sarà comprensiva, vedrai.
Oggi ti parlo dell’ammirevole iniziativa “Lascia un libro, prendi un libro”, del siciliano e (lodevolmente) visionario Giuseppe Rapisarda.
La prendo da lontano, ma giusto un filo.
Passeggiavo per il Pont Neuf nella spettacolare cornice parigina, stava facendo buio e il cielo era coperto di nubi violacee. Di lì a poco si sarebbe messo a piovere. È stato allora che mi sono accorto di quel mucchietto di libri abbandonati su una panchina. È successo qualche anno fa, il book sharing era ancora quasi sconosciuto in Italia, e ricordo di aver pensato qualcosa tipo: «Chi è quel mammalucco che dimentica una pila di libri in giro?». Ne ho aperto uno e ho scoperto la magia: ciascuno di essi aveva un’etichetta ed era siglato, numerato e rintracciabile, pronto per essere prestato a chi voleva leggerlo, a condizione che lo restituisse una volta letto. Anche a Bryant Park, a New York, mi è capitato di incontrare qualcosa di simile. Era un vero e proprio baracchino, quella volta, scaffali interi di libri a disposizione. Quei libri, ho scoperto poi, andavano restituiti in luoghi specifici detti punti di rilascio, ce n’erano (e molti) anche in Italia, ma da queste parti quella dello scambio non era ancora una pratica granché diffusa. “Lascia un libro, prendi un libro” ripropone quel metodo di scambio di libri, ma con qualche differenza volta a snellirne il processo.
Ne ho parlato con la mente del progetto, un instancabile viaggiatore e amante della natura di nome Giuseppe Rapisarda che, a 56 anni, dopo una carriera aziendale nel settore medicale, ha deciso di prendersi un decennio sabbatico (che invidia!) con lo scopo di viaggiare e incontrare nuovi paesi, costumi e usanze. L’idea di “Lascia un libro, prendi un libro” nasce in Giuseppe proprio da queste esperienze, con l’intento di importare nella sua comunità i comportamenti virtuosi delle culture e dei paesi conosciuti durante i suoi viaggi.

Come funziona “Lascia un libro, prendi un libro”?
Esistono punti fissi di condivisione, dove trovare e scambiare i libri. Questi punti possono essere negozi o sedi di associazioni; al chiuso, perché i libri non siano rovinati da vandali o dalle intemperie. L’utente ha la possibilità di visitare il punto di condivisione e scegliere il libro che preferisce.
Una specie di biblioteca allargata, dunque.
Esatto, una biblioteca diffusa per tutta l’Italia.
Chiunque può prendere un libro?
Purché ne lasci un altro in cambio. Per il momento, però, non ci occupiamo di libri scolastici o di enciclopedie.
Come e quando ha preso forma il progetto?
Durante i miei viaggi all’estero, ho visto diverse postazioni pubbliche dei libri, da qui l’idea di realizzarne due o tre nel mio paese. La cosa sarebbe finita lì, ma visto che piaceva ho continuato. Sono partito da Belpasso per poi allargarmi ai paesi, alle province e alle regioni vicine. Era la primavera del 2017.
Qual è stato il primo punto di condivisione creato?
Il primo è stato creato nel panificio che sta a dieci metri da casa mia. È un punto molto frequentato.
In cosa differisce “Lascia un libro, prendi un libro” dal consueto book sharing (dalla piattaforma Bookcrossing.com, per esempio), a parte che nel vostro caso i punti di condivisione sono al chiuso e riparati?
Il nostro progetto è molto snello e pragmatico, poche regole e pochi convenevoli. Focalizziamo la nostra attenzione sulla circolazione dei libri e sulla promozione della lettura. Il Bookcrossing nasce per monitorare gli spostamenti dei libri condivisi. A ogni libro assegnano un codice e ne monitorano gli spostamenti. Prima ancora lo facevano con le banconote, anche loro dotate di un numero di serie univoco. Noi sconsigliamo di lasciare dei libri in giro a caso (nello scompartimento di un treno, per esempio, o nel tavolo di un bar, nella panchina di un parco, ecc.), suggeriamo piuttosto di strutturare questa pratica, trovando un esercente che metta a disposizione un piccolo spazio dove ospitare questi libri.
Chi volesse ospitare un punto di condivisione che cosa dovrebbe fare?
Dovrebbe contattarmi su Facebook e avere a disposizione uno spazio espositivo in cui poter collocare almeno una ventina di libri. Avviata l’attività, i punti di condivisione ricevono spesso donazioni spontanee da parte dei lettori che regalano i propri libri senza volerne altri indietro. L’attività è gratuita, in ogni suo aspetto.

A giudicare dal tipo di progetto intrapreso sarebbe facile immaginare una sua passione per i libri. È un appassionato di lettura oltre che di viaggi?
Come le dicevo, questo progetto è nato per caso. La mia idea iniziale era quella di allestire qualche punto nella mia comunità. Di fatto poi sono rimasto “prigioniero” di questa iniziativa e della passione che metto nelle cose che faccio. Ho visto che il progetto piaceva, che le persone ci seguivano, ci scrivevano, ci chiedevano come allestire nuovi punti, ci segnalavano punti già esistenti sul territorio, quindi non mi sono più fermato. Questa attività mi occupa quasi l’intera giornata, e da oltre tre anni e mezzo ci lavoro gratuitamente quasi tutti i giorni, dedicandovi la cosa più preziosa che ho: il mio tempo.
Per arrivare alla laurea e per la mia attività lavorativa ho passato tanti anni leggendo libri. Nel mio tempo libero non sono un super-lettore; sono una persona tenace, capace di strutturare i progetti e seguirli fino al superamento degli obiettivi. Ho svolto studi tecnico-scientifici e, mentre gli altri studiavano materie umanistiche, io frequentavo i laboratori di aggiustaggio, di fisica, di chimica, ecc. Ho sviluppato, in questo modo, una spiccata attitudine alla risoluzione dei problemi. Leggo saggi, quasi mai romanzi o libri di avventura. Passando oltre sei mesi l’anno in viaggio, preferisco vivere le avventure in prima persona e non leggere quelle inventate da altri. Ad oggi ho fatto oltre trecento viaggi e visitato circa il 70% del nostro pianeta, e se le mie condizioni di salute me lo consentiranno, conto di visitarlo tutto.
Per concludere Giuseppe Rapisarda vuole lanciare un appello.
Agli amministratori, perché creino dei punti di recupero libri nelle isole ecologiche, investano nella cultura e premino i comportamenti virtuosi nella propria comunità; agli esercenti, perché mi contattino per ospitare un punto di condivisione (è gratis!); e ai lettori, perché utilizzino questa opportunità e la trasmettano ai propri figli; e a tutti: stiamo provando ad allestire un punto di recupero e condivisione gratuita dei libri in ogni comune e stiamo facendo una sorta di censimento di tutti i punti di scambio di libri sul territorio italiano: segnalateci i punti della vostra zona!

“Lascia un libro, prendi un libro” è un progetto per il recupero e la diffusione gratuita di libri nato a Belpasso, un paesino ai piedi dell’Etna (34 punti di condivisione attualmente presenti per 18mila abitanti), e in crescita esponenziale. In questo momento più di 150mila sono i libri diffusi, 500 i punti di condivisione e 200 le città coinvolte in tutte le regioni italiane. Un progetto di scambio che unisce, che regala cultura e condivisione, che non mira a portare le persone dai libri ma i libri alle persone. I punti di condivisione sono infatti scelti tra i luoghi della quotidianità: dal panettiere al parrucchiere, dal supermercato allo studio medico, ecc.
Un progetto ambizioso, che mi sento di sostenere e divulgare perché basato su valori che anch’io condivido pienamente: cultura, sostenibilità e solidarietà.
Intervista di Francesco Montonati
Di seguito i contatti
Pagina Facebook







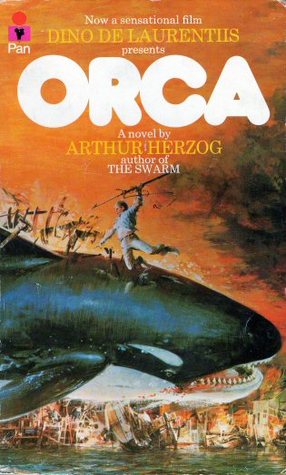



Devi effettuare l'accesso per postare un commento.